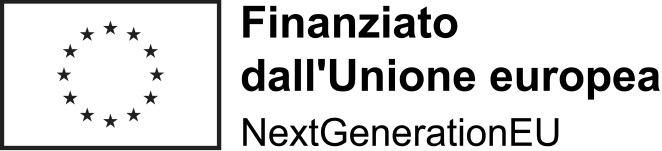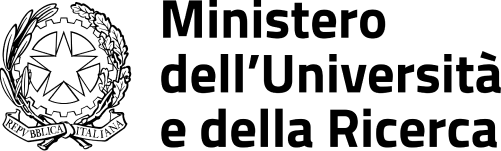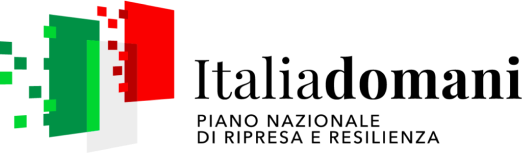Pubblicato il: 26-8-2025
Condividi
Condividi
Correlato a

Nel novembre del 2028 a Barcellona scadranno le licenze per abitazioni adibite ad affitti turistici. Il sindaco della città Jaume Collboni ha dichiarato che queste non verranno rinnovate. A partire dal 2029, tecnicamente, queste case dovranno essere affittate a uso residenziale. Secondo quanto dichiarato da Collboni, la pratica dell’overtourism sta mettendo in seria difficoltà il diritto alla casa. Gli affitti a Barcellona sono cresciuti in questi anni del 68 per cento. L’accesso a una casa a prezzi abbordabili non può diventare un fattore di disuguaglianza, soprattutto per i giovani, ha dichiarato sempre il sindaco.
In questi ultimi anni il tema dell’overtourism, soprattutto in Europa, è diventato di fondamentale importanza. Vari governi europei, a partire da quello italiano, hanno visto nel turismo una possibilità di crescita economica e occupazionale. L’Europa, d’altronde, è una delle mete più gettonate anche per i turisti esteri, sapendo coniugare l’aspetto naturale, storico e dei servizi. Prima della pandemia di SarsCov-2, l’Europa arrivava ad accogliere 713 milioni di arrivi, che contribuivano in modo significativo al PIL e all'occupazione. Con la ripresa del turismo internazionale, nel 2023 si sono raggiunti picchi superiori a quelli pre pandemia.
Questo ha portato, come dimostra l’esempio di Barcellona, a un dibattito tra politici e amministratori, ricercatori e opinione pubblica riguardo al fenomeno dell’overtourism.
Su questo aspetto è stato recentemente pubblicato un paper all’interno del progetto di ricerca Grins. Angela Stefania Bergantino, professoressa ordinaria all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e coautori hanno contribuito alla letteratura con un’analisi che ne mostra le varie sfaccettature.
La ricerca è stata citata anche nell’articolo di Marco Brando “Quali soluzioni per l’overtourism?” pubblicato su Treccani Atlante, sottolineando come l’Italia, pur essendo una delle principali destinazioni turistiche in Europa, rischi di subire gli effetti negativi di un turismo incontrollato. In questo contesto, lo studio offre un contributo significativo, proponendo un approccio innovativo per individuare le località più vulnerabili all'overtourism, come evidenziato nel caso della Puglia.
Partiamo dalla definizione di overtourism. Il fenomeno è stato trattato in letteratura fin dagli anni ‘60, con autori che sottolineavano gli effetti negativi del turismo. Negli anni ‘80 ci si è orientati sempre di più verso l’idea di considerare la capacità di carico turistico (carrying capacity) dei singoli luoghi.
In particolare, la ricerca si concentrava sul numero di visitatori che, una volta superato, avrebbe portato a conseguenze avverse sulle località visitate, in particolare riguardo agli effetti sulla popolazione residente. Questo ha portato all’introduzione dell’indicatore di Tourist Carrying Capacity (TCC), utile a individuare il livello-limite al di sotto del quale il fenomeno turistico non genera effetti negativi. Questo dipende dal mix di vari fattori di tipo economico, sociale e ambientale. Ad esempio, un elevato afflusso di turisti nello stesso periodo può avere riflessi sull’inflazione, come si è verificato in Svezia in conseguenza del The Eras Tour di Taylor Swift, o sulla possibilità dei residenti di affittare o acquistare un’abitazione. Questo rischia di esacerbare le disuguaglianze sociali, in molti casi già presenti, nel territorio.
Il fenomeno è strettamente collegato al calo dei prezzi del trasporto aereo che ha permesso a molte più persone di viaggiare, ma che allo stesso tempo comporta non pochi problemi dal punto di vista ambientale.
Proprio in virtù di queste problematiche associate al fenomeno è necessario che la ricerca individui, grazie alla mole di dati estremamente granulari che oggi si possono avere a disposizione, quali sono le località più vulnerabili in termini di overtourism. Dati di questo tipo sono essenziali per definire qualsiasi strategia di intervento puntuale e localizzata che consenta di mitigare gli effetti e favorire forme più sostenibili di turismo.
Questo è proprio il cuore dell’articolo pubblicato da Bergantino, Buongiorno e Intini. Lo studio ha adottato un approccio innovativo e multidimensionale, vista la natura sfaccettata e complessa del fenomeno, che include, oltre alla considerazione dell’ impatto ambientale, anche fattori come l'intensità del trasporto aereo, il valore economico generato dal turismo, la diffusione degli affitti a breve termine e la vicinanza a siti UNESCO.
La prima parte dell’analisi si basa sulla costruzione di un indice, detto Indice Sintetico di Pressione Turistica (TPSI), per varie località mediterranee, costruito su basi di dati Eurostat relative al numero di pernottamenti, al tasso di crescita del turismo e ai picchi stagionali. Attraverso questo indice, si è potuto individuare nella Puglia una regione particolarmente a rischio, proprio perché i valori di tutti e tre gli indici presi in considerazione sono oltre il valore mediano della distribuzione. La regione ha infatti visto un incremento notevole del turismo negli anni della ripresa post-Covid, con una crescita rispetto agli anni precedenti seconda dietro solo alla Sardegna. A giocare un ruolo fondamentale è stato l’aumento del traffico aereo diretto verso la regione.
L'analisi si è poi concentrata a livello dei singoli comuni pugliesi, utilizzando una serie di indicatori specifici per valutare il rischio di overtourism. In particolare, sono stati considerati, a partire da dati comunali (indicati con la lettera C), provinciali (lettera P), regionali (lettera R):
I dati raccolti hanno permesso una classificazione per quintili, quindi in una scala da 1 a 5, del rischio di overtourism. L’analisi ha mostrato un’elevata eterogeneità delle 15 mete più importanti della regione Puglia: sono in particolare le mete di dimensioni minori quelle più esposte. Questo perché centri come Bari, Lecce e Monopoli possono far leva su una maggior diversificazione economica che non le rende eccessivamente dipendenti dal turismo.
Lo studio ha inoltre rivelato che gli affitti brevi hanno contribuito a esacerbare i problemi riguardanti l’accessibilità degli alloggi, esasperando le tensioni tra residenti e turisti. Un altro fattore cruciale è la vicinanza ad aeroporti internazionali: questi infatti permettono un maggior afflusso di persone, esponendo maggiormente al rischio di overtourism.
Di particolare importanza, riguardo all’aspetto economico, è proprio la dipendenza delle zone dal turismo, che in certe aree ha già superato livelli di guardia: se è vero che l’economia turistica porta benefici evidenti, è altrettanto vero che rende le località ad alta frequentazione di visitatori particolarmente esposte alle oscillazioni del numero di turisti in arrivo, come si è ben visto in periodo di Covid-19.
La crescente dipendenza dal turismo è un fattore di cui è necessario tener conto nelle politiche locali e territoriali. Per questo, sottolineano gli autori, è indispensabile pensare a modelli quanto più sostenibili e resilienti possibile di economia turistica, in grado di bilanciare il benessere economico con gli aspetti sociali e ambientali.
Alla luce di quanto detto, è più che opportuno che gli effetti negativi del turismo di massa entrino nell’agenda di legislatori e amministratori. E’ urgente cercare di ridistribuire i flussi sia nello spazio sia nel tempo, ad esempio promuovendo il turismo in bassa stagione, diversificando l’offerta e introducendo meccanismi di prezzo per contenere l’afflusso nei periodi critici. Servono strategie mirate per incentivare i soggiorni più lunghi, ridurre l’impatto del turismo “mordi e fuggi” e migliorare la qualità dell’esperienza, sia per i turisti sia per i residenti.
Un ulteriore nodo è rappresentato dalla crescita degli affitti brevi, che in molte città interne ha contribuito al rincaro degli alloggi e all’espulsione dei residenti dai centri storici. Servono regolamenti più stringenti, strumenti fiscali mirati e una pianificazione urbana che tenga conto del diritto all’abitare. La prossimità agli aeroporti, infine, espone alcune aree a un turismo di massa alimentato dal traffico low-cost: per contrastarlo è utile incentivare la scoperta di mete alternative, meno esposte alla saturazione.
2026
2026
Sostenibilità dei territori e resilienza: a Bari l’evento finale dello Spoke 7 del progetto Grins
Il 16 gennaio 2026 all’Università di Bari il terzo incontro plenario dello Spoke 7: risultati della ricerca, strumenti data-driven e confronto diretto con istituzioni, im...
2025
2025
Il 3 e 4 dicembre il Campus San Giobbe dell’Università Ca’ Foscari Venezia ospita il terzo workshop di finanza sostenibile, con sessioni dedicate a ESG, innovazione digit...
2025
Quando il legno rinasce: un workshop tra scienza, economia e territorio
L’11 luglio 2025, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si terrà il workshop "Il legno che rinasce per territori resilienti e sostenibili", organizzato dal...
Lo studio coordinato dalla professoressa Angela Stefania Bergantino mostra le profonde disuguaglianze nell'accesso ai servizi ospedalieri di Roma attraverso il sistema di...
2025
2025
L'Università di Bari alla conferenza annuale dell’International Transportation Economics Association (ITEA), in programma dal 24 al 29 giugno 2025 presso la Northwestern ...
Mobilità e Transizione Energetica: sfide e opportunità al centro di Focus ESG
La professoressa Angela Stefania Bergantino e il presidente di UNEM Gianni Murano a Focus ESG per parlare di mobilità e sostenibilità ambientale.
2025
2025
Si è svolto il 18 e 19 maggio 2025, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università di Bari “Aldo Moro”, il workshop internazionale ...
Capacità territoriali a confronto: il benchmarking come guida per la sostenibilità territoriale
Lo Spoke 7 sviluppa un sistema di benchmarking per misurare resilienza e attrattività dei territori italiani, con un osservatorio e una dashboard interattiva per politich...
Lo studio condotto dal gruppo di ricerca dell’Università di Bari ha analizzato l’impatto delle politiche di sconto sui carburanti adottate dal Friuli Venezia Giulia per c...
I dati pubblici sono un’arma a doppio taglio? Le performance degli enti locali e il caso OpenCivitas
Opendata e performance degli enti locali. Un focus sulla ricerca di Ben Lockwood, Francesco Porcelli, Antonio Schiavone, Michela Redoano. Il lavoro coinvolge anche ricerc...
In un recente lavoro pubblicato su Scientific Reports, i ricercatori del team multidisciplinare di UNIBA dello Spoke 7 di Grins hanno utilizzato immagini satellitari di l...
Spesso si è pensato che per diminuire i cosiddetti divari digitali si dovesse puntare allo sviluppo tecnologico di certe aree, ma gli studi ci dicono che prima di tutto c...
Lo stato dell'arte della ricerca dello Spoke 7 di Grins, coordinato dall'Università di Bari "Aldo Moro".
Ce lo dice uno studio dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" sulla regione Puglia.
Nell’intervista ad Angela Stefania Bergantino si parla del lavoro di ricerca dello Spoke 7, passando per temi come la resilienza territoriale, la mobilità sostenibile, i...
Nuovi finanziamenti alla ricerca con il bando a cascata di Spoke 7 e UniBa
Sono aperte fino al 3 maggio le candidature per il bando a cascata promosso dall’Università di Bari. Cinque i progetti di ricerca industriale finanziabili per un totale d...
Il successo del Pnrr? Dipende dalla capacità di spesa dei comuni
Un articolo realizzato da Angela Stefania Bergantino e Francesco Porcelli, pubblicato su lavoce.info e qui riprodotto per concessione della redazione.
Sono aperte da lunedì 5 febbraio fino al 9 marzo le candidature per il nuovo bando a cascata lanciato dall'Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.
L'Università degli Studi di Bari ha aperto sette bandi per posizioni di ricerca post-doc presso il proprio Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa
2023
2023
La sostenibilità dei territori al centro delle attività di ricerca dello Spoke 7 di Grins, il partenariato esteso finanziato dal PNRR per la sostenibilità economica di si...
Fondazione GRINS
Growing Resilient,
Inclusive and Sustainable
Galleria Ugo Bassi 1, 40121, Bologna, IT
C.F/P.IVA 91451720378
Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 (Infrastruttura e ricerca), Componente 2 (Dalla Ricerca all’Impresa), Investimento 1.3 (Partnership Estese), Tematica 9 (Sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori).