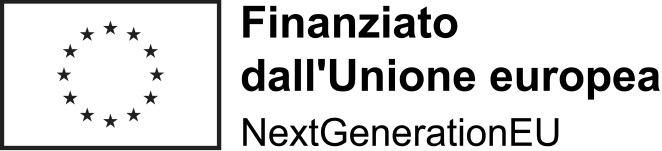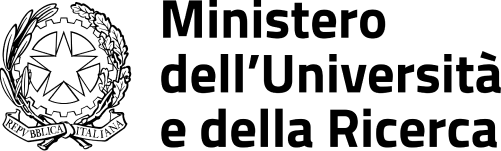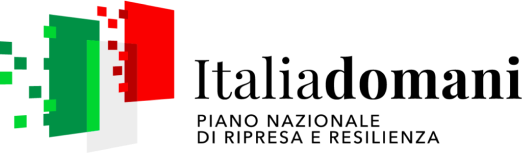Pubblicato il: 7-11-2025
Condividi
Condividi

Ma mentre il dibattito pubblico si è concentrato a lungo sui decreti attuativi e sugli incentivi, le amministrazioni locali si sono trovate a dover affrontare una questione molto più concreta e immediata: quale forma giuridica scegliere?
Non si tratta di una scelta burocratica di routine. La "scatola giuridica" condiziona tutto: i tempi di costituzione, le modalità di coinvolgimento dei partner, le strategie di investimento, persino la capacità di attrarre cittadini e imprese. È la differenza tra una CER che decolla rapidamente e una che si impantana nelle procedure, tra un progetto che genera valore condiviso e uno che resta lettera morta.
L'esperienza concreta di tre territori italiani – Provincia di Livorno, Unione Montana Valtellina di Sondrio (CER Valtellina di Sondrio) e Provincia di Como (CER Fondazione Energie Provincia Como) - offre un laboratorio ideale per capire come diverse scelte giuridiche abbiano generato percorsi, opportunità e criticità completamente differenti. Tre strade, tre filosofie, tre lezioni che possono orientare chi oggi si trova davanti al bivio della costituzione di una CER di area vasta.
La Provincia di Livorno ha scelto la strada della certezza assoluta. Prima lo studio, poi l'azione. Prima l’analisi tecnico-economica dettagliata del potenziale fotovoltaico e dei consumi elettrici di ogni edificio pubblico, poi la costituzione formale della CER in forma di cooperativa. Un approccio che potrebbe sembrare eccessivamente prudente, ma che si rivela in realtà una strategia precisa e strutturata.
Il percorso è iniziato con la mappatura sistematica del patrimonio immobiliare pubblico provinciale e comunale di 8 amministrazioni pubbliche che hanno aderito al progetto, e con la definizione dei perimetri delle cabine primarie di trasformazione, come previsto dalla normativa vigente, per individuare le configurazioni tecnicamente ammissibili alla condivisione incentivata di energia. Questo ha permesso di proporre la creazione di sei configurazioni energetiche distinte, ma integrate in un unico soggetto giuridico cooperativo, in grado di gestire l'intero progetto con efficienza amministrativa e conformità normativa.
Sono stati censiti 613 POD di consumo, di cui 398 pubblici e 215 privati, ed è stata dimensionata una potenza fotovoltaica installabile pari a 2.518 kWp, distribuita su edifici strategici per massimizzare l’autoconsumo e la condivisione.
Ciascuna delle otto amministrazioni comunali coinvolte ha preliminarmente sottoposto alla propria Giunta e successivamente al Consiglio Comunale la documentazione tecnico-economica predisposta, attestante – in via potenziale – la fattibilità dell’intervento e la sostenibilità economico-finanziaria della partecipazione alla costituenda Comunità Energetica. A seguito dell'approvazione con delibera favorevole, ogni Comune ha formalizzato la propria adesione all’iniziativa.
Tutta la documentazione approvata, comprensiva delle delibere consiliari e delle valutazioni tecniche, deve poi essere raccolta e trasmessa alla Corte dei conti. In base a quanto previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, la Corte è infatti chiamata a esprimere un parere preventivo sulla partecipazione di enti pubblici a soggetti giuridici esterni, con l’obiettivo di verificare la solidità dell’operazione, il rispetto dei principi di economicità e l’assenza di rischi finanziari per le amministrazioni coinvolte.
La forma cooperativa ha permesso di strutturare un modello di governance democratica, dove ogni comune membro ha voce proporzionale al capitale sociale sottoscritto, determinato sulla base della popolazione residente. I contributi vanno dai 2.000 € dei comuni più piccoli ai 15.000 € di quelli più grandi, per un capitale sociale complessivo iniziale di 83.750 €.
Il modello toscano privilegia la solidità procedurale e la trasparenza democratica. Da Statuto, ogni decisione passa da assemblee formali, ogni investimento viene validato collegialmente, ogni beneficio economico viene distribuito secondo criteri chiari e condivisi. È un approccio che richiede tempo ma che minimizza i rischi legali e massimizza la legittimazione sociale del progetto.
Questa scrupolosità ha un prezzo: i tempi. Dall’inizio delle attività propedeutiche alla redazione dello studio di fattibilità è trascorso poco più di un anno e, ad oggi, la documentazione necessaria sta per essere trasmessa alla Corte dei conti. Ma in un settore in rapida evoluzione come quello dell’energia, questa apparente lentezza si è trasformata in vantaggio competitivo: quando la CER sarà operativa, disporrà già di un modello tecnico, economico e normativo consolidato, pronto ad affrontare le sfide della transizione energetica con strumenti efficaci e partecipati.
All'opposto di Livorno, la Comunità Montana della Valtellina di Sondrio ha scelto la velocità. Prima la costituzione dell'associazione senza scopo di lucro, poi gli studi di fattibilità. Un approccio "learn by doing" che ha permesso di diventare operativi in tempi record, evitando i lunghi iter burocratici.
La CER Valtellina di Sondrio, nata nel 2024, coinvolge 27 amministrazioni locali, tra cui Comuni e la Comunità Montana di Sondrio e 206 soci privati. La forma associativa è stata scelta consapevolmente per la sua flessibilità costitutiva e gestionale. Nessun passaggio obbligato in Corte dei conti, procedure semplificate per le modifiche statutarie, facilità nell'accogliere nuovi membri: circa 10 MWp di impianti fotovoltaici sono in corso di progettazione ed allaccio alla rete da parte di privati. Un modo per essere sul mercato dell'energia elettrica il prima possibile ed aggiustare il tiro strada facendo.
La strategia si è rivelata vincente. L'associazione si è costituita in pochi mesi e ha subito iniziato a lavorare sulla valorizzazione energetica di impianti fotovoltaici già in corso di allaccio sul territorio. Non grandi investimenti pubblici ex novo, ma attrazione di quelli privati: una scelta che permetterà di generare i primi ricavi quasi immediatamente.
Il focus è sulla condivisione dell'energia tra i Comuni membri e i cittadini del territorio valtellinese. Un modello che punta sulla partecipazione diffusa piuttosto che sui grandi investimenti infrastrutturali. I cittadini possono aderire alla CER portando i propri impianti domestici o semplicemente diventando consumatori dell'energia condivisa prodotta dagli impianti.
La governance associativa permette assemblee snelle e decisioni rapide. Non ci sono i vincoli procedurali della cooperativa, ma nemmeno la rigidità burocratica degli enti pubblici tradizionali. È un modello che funziona particolarmente bene in contesti territoriali coesi, dove i rapporti fiduciari sostituiscono le procedure formali.
Naturalmente, questa agilità ha delle contropartite. La forma associativa può presentare limitazioni nell'attrarre capitali privati significativi, e la mancanza di procedure standardizzate può generare incertezze in situazioni di conflitto. Ma questi rischi potrebbero essere stati giudicati accettabili in cambio della rapidità operativa.
L'esperienza valtellinese dimostra che un approccio pragmatico e flessibile può accelerare significativamente l'avvio delle CER, soprattutto quando si punta sulla valorizzazione dell'esistente piuttosto che su nuovi grandi investimenti.
La Provincia di Como ha scelto una strada completamente diversa, optando per una fondazione di partecipazione. Una forma giuridica meno comune nel settore energetico ma che offre caratteristiche uniche per la gestione di partnership complesse che coinvolgono soggetti pubblici, privati e del terzo settore.
La fondazione di partecipazione è una figura ibrida che combina la stabilità patrimoniale tipica delle fondazioni con la flessibilità partecipativa delle associazioni. Permette l'ingresso di fondatori, partecipanti e sostenitori con ruoli e responsabilità differenziate, facilitando la costruzione di partenariati strategici complessi.
In questo modo è agile coinvolgere Comuni ed imprese del territorio, cooperative sociali, associazioni di categoria. La fondazione permette di costruire una governance multilivello dove ogni stakeholder può trovare il proprio spazio ottimale.
Lo studio di fattibilità è sviluppato in parallelo alla costituzione, concentrandosi inizialmente sul patrimonio immobiliare provinciale ma mantenendo aperte le porte per successive espansioni. Questa strategia ha permesso di iniziare con un nucleo solido e crescere progressivamente, integrando via via nuovi partner e nuove progettualità.
Gli obiettivi della fondazione comasca sono particolarmente ambiziosi: non solo l'utilizzo sistemico del patrimonio pubblico per la produzione di energia rinnovabile, ma anche il coinvolgimento strutturato degli attori economici e sociali del territorio nella transizione energetica. La CER diventa così uno strumento di sviluppo territoriale integrato, non solo di produzione energetica.
La governance della fondazione prevede un consiglio di amministrazione rappresentativo delle diverse anime del progetto, un collegio di esperti per le decisioni tecniche, e assemblee periodiche di tutti i partecipanti per le scelte strategiche. È un modello complesso ma che garantisce il bilanciamento degli interessi e la valorizzazione delle competenze specifiche di ogni partner.
Questa complessità gestionale ha naturalmente dei costi in termini di tempo e risorse dedicate al coordinamento. Ma Como ha scommesso che questi costi aggiuntivi sarebbero stati più che compensati dalla capacità di attrarre competenze, risorse e progetti che difficilmente sarebbero stati accessibili con forme giuridiche più semplici.
I primi risultati sembrano confermare questa intuizione: la fondazione ha già attirato l'attenzione di diversi investitori privati interessati a co-finanziare progetti di innovazione energetica. Contestualmente, sta per avviarsi una nuova fase operativa: uno studio tecnico dettagliato presso 40 Comuni, finalizzato a mappare le potenzialità di produzione da impianti fotovoltaici e i profili di consumo.
L’obiettivo è valutare quali porzioni di energia potrebbero essere effettivamente considerate come condivisibili nell’ambito di future configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili.
Al di là delle caratteristiche formali, ciò che emerge dal confronto tra i tre modelli sono le diverse filosofie operative che li sottendono. Livorno ha scelto la certezza procedurale, investendo tempo nella fase preparatoria per minimizzare i rischi futuri. Valtellina ha privilegiato la velocità operativa, accettando di aggiustare il percorso strada facendo. Como ha puntato sull'innovazione relazionale, costruendo una architettura complessa per massimizzare le opportunità di partnership.
Queste diverse filosofie si riflettono concretamente nei tempi di realizzazione, nelle modalità di finanziamento e negli impatti territoriali. La cooperativa livornese non è ancora costituita a più di un anno ma ha ottenuto un finanziamento pubblico significativo e un consenso territoriale molto solido.
L'associazione valtellinese si è costituita molto rapidamente e potrà generare i primi ricavi quasi immediatamente perché ha fornito ai privati (cittadini ed aziende) la “scatola” giuridica necessaria per l’ottenimento del contributo in conto capitale previsto dal PNRR per l’acquisto di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in configurazioni di condivisione dell’energia, ma deve ancora consolidare la propria base finanziaria per progetti più ambiziosi. La fondazione comasca ha impiegato 5 mesi per la costituzione e l'avvio, ma ha già ottenuto manifestazioni di interesse per co-finanziamenti privati superiori a quelli delle altre due esperienze messe insieme.
Anche gli impatti sui territori sono diversi. Livorno potrà generare benefici economici diretti ma distribuiti su una base ampia di pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, cittadini. Valtellina ha attivato alcuni servizi di consulenza energetica per i cittadini. Como non ha ancora impatti diretti misurabili, ma ha già generato un ecosistema di relazioni e progettualità che promette ricadute significative nel medio termine.
Interessante anche l'analisi dei costi di gestione. La cooperativa livornese ha costi amministrativi relativamente contenuti ma vincolati dalle procedure formali. L'associazione valtellinese ha costi operativi minimi ma deve investire risorse significative per mantenere il coinvolgimento dei membri. La fondazione comasca ha costi di coordinamento più elevati ma può distribuirli su una base di attività e ricavi più ampia.
Al di là delle specificità di ogni modello, l'analisi dei tre casi evidenzia alcuni fattori critici di successo comuni. Il primo è la chiarezza degli obiettivi strategici: tutte e tre le esperienze hanno definito sin dall'inizio cosa volevano ottenere e hanno costruito di conseguenza la propria architettura organizzativa.
Il secondo fattore è la capacità di costruire e mantenere consenso territoriale. Livorno lo ha fatto attraverso la trasparenza procedurale e la partecipazione democratica. Valtellina attraverso la rapidità dei risultati e la flessibilità nell'accogliere nuove adesioni. Como attraverso la costruzione di una rete di stakeholder con interessi convergenti.
Il terzo elemento critico è la competenza tecnica e gestionale del team operativo. Tutte e tre le CER hanno investito risorse significative nel supporto tecnico, riconoscendo che la complessità normativa e tecnologica del settore richiede professionalità specifiche che raramente sono disponibili all'interno delle amministrazioni pubbliche tradizionali.
Infine, tutte e tre le esperienze hanno dovuto sviluppare capacità di adattamento e resilienza rispetto ai cambiamenti normativi e di mercato. Il settore delle energie rinnovabili evolve rapidamente, e le CER che riescono a mantenere flessibilità strategica pur avendo solidità organizzativa sono quelle che ottengono i risultati migliori.
L’analisi comparata dei tre modelli – Cooperativa (Livorno), Associazione (CER Valtellina di Sondrio) e Fondazione di partecipazione (CER Fondazione Energie Provincia Como) – mette in luce distinti punti di forza, criticità, opportunità e minacce, fornendo una visione strategica adatta a lettori istituzionali e policy maker.
| Modello | Punti di Forza (Strengths) | Punti di Debolezza (Weaknesses) | Opportunità (Opportunities) | Minacce (Threats) |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativa (Livorno) | Governance democratica e trasparente; forte legittimazione istituzionale; solidità tecnico-amministrativa; struttura replicabile in contesti pubblici. | Tempistiche di costituzione molto lunghe; passaggi procedurali rigidi (es. Corte dei conti); rischio di lentezza decisionale con l'espansione. | Accesso stabile agli incentivi pubblici; possibilità di replicare il modello in altri territori; incremento della domanda di CER sociali e redistributive. | Rigidità nel rispondere a contesti in rapido mutamento; rischio di appesantimento burocratico; concorrenza di modelli più agili. |
| Associazione (CER Valtellina di Sondrio) | Flessibilità costitutiva e operativa; tempi rapidi di avvio; valorizzazione immediata di impianti di prossimo allaccio alla rete; modello adattabile e leggero. | Debolezza patrimoniale; limitata attrattività per capitali esterni; possibile fragilità nella governance; rischio di instabilità nel tempo. | Apertura a nuovi membri e sperimentazioni rapide; crescita dell’interesse locale verso l’autoproduzione energetica. | Saturazione del modello in assenza di patrimonializzazione; cambiamenti normativi possono compromettere la sostenibilità; scarsa resilienza a crisi interne. |
| Fondazione di Partecipazione (CER Fondazione Energie Provincia Como) | Governance multilivello flessibile; attrazione di soggetti pubblici, privati e del terzo settore; forte capacità di innovazione; adattabilità alla crescita progressiva. | Alta complessità gestionale; costi di coordinamento elevati; possibile conflitto tra stakeholder eterogenei; dipendenza da leadership forti. | Espansione di fondi pubblici e privati per progetti complessi; sinergie con altri ambiti (welfare, mobilità); possibilità di accedere a fondi europei competitivi. | Dipendenza dal contesto locale favorevole; rischio di eccessiva politicizzazione o rigidità; incertezza giuridica per forme ibride in ambito energetico. |
L’analisi SWOT comparata, sintetizzata nella tabella 1, permette di evidenziare come ciascuna forma giuridica porti con sé un insieme coerente di caratteristiche strutturali, che si riflettono in punti di forza distintivi, ma anche in vulnerabilità specifiche.
La cooperativa, come mostrato dal caso livornese, si distingue per la solidità istituzionale e per la capacità di garantire trasparenza e inclusione democratica, a fronte di tempi lunghi e una minore agilità decisionale.
L’associazione, sperimentata con successo in Valtellina, si configura come la forma più flessibile e operativa nel breve termine, ma rischia di soffrire in assenza di una struttura patrimoniale forte e di una governance stabile.
La fondazione di partecipazione, adottata a Como, emerge come il modello più sofisticato, capace di attrarre soggetti eterogenei e risorse qualificate, ma al costo di una complessità gestionale elevata che richiede competenze specifiche e un solido coordinamento strategico.
Dal punto di vista delle opportunità, tutti e tre i modelli sono potenzialmente ben posizionati per intercettare le traiettorie emergenti della transizione energetica, soprattutto in termini di accesso a nuovi strumenti di finanziamento, sviluppo di servizi integrati e coinvolgimento attivo della cittadinanza.
Le minacce, invece, appaiono in larga misura comuni: l’instabilità normativa, la concorrenza da parte di operatori privati e il rischio di costruire strutture organizzative non resilienti nel tempo. In questo senso, la SWOT non si limita a classificare vantaggi e svantaggi: diventa uno strumento utile per mettere in relazione le forme giuridiche con le condizioni territoriali, le capacità operative e gli obiettivi strategici delle amministrazioni locali.
L'analisi comparata permette di costruire una matrice decisionale che può orientare territori e amministrazioni nella scelta della forma giuridica più adatta per la propria CER di area vasta.
Per progetti con forte componente sociale, dove l'obiettivo primario è la redistribuzione del valore energetico e l'inclusione delle fasce più deboli della popolazione, la cooperativa rappresenta la soluzione naturale. La governance democratica, la trasparenza decisionale e i meccanismi di solidarietà tipici della forma cooperativa la rendono ideale per questo tipo di obiettivi.
Quando l'urgenza operativa è prioritaria, quando si vuole entrare rapidamente nel mercato energetico magari valorizzando impianti in corso di allaccio, l'associazione senza scopo di lucro offre la flessibilità e la rapidità necessarie. È particolarmente adatta a contesti territoriali coesi dove i rapporti fiduciari possono sostituire efficacemente le procedure formali.
Per progetti ambiziosi che richiedono partnership complesse con coinvolgimento di attori eterogenei - pubblici, privati, del terzo settore - la fondazione di partecipazione fornisce gli strumenti più sofisticati. È la scelta ottimale quando si vuole costruire un ecosistema di innovazione energetica che vada oltre la semplice produzione e condivisione di energia.
La matrice deve però considerare anche fattori contingenti: la presenza di competenze tecniche specifiche nel territorio, la disponibilità di risorse finanziarie iniziali, il grado di coesione sociale e istituzionale, la complessità del patrimonio immobiliare da valorizzare.
L'esperienza di Livorno, Valtellina e Como dimostra che non esiste una formula magica per le CER di area vasta. Esistono invece approcci diversi, ciascuno con proprie logiche, vantaggi e criticità. La scelta della forma giuridica non è un dettaglio tecnico ma una decisione strategica che condiziona tutto il percorso successivo.
Quello che accomuna le tre esperienze di successo è la consapevolezza che costituire una CER sovracomunale significa costruire un sistema complesso che deve integrare dimensioni tecniche, economiche, giuridiche e sociali. Non basta copiare uno statuto o replicare un modello organizzativo: bisogna adattare la soluzione alle specificità del territorio e agli obiettivi che si vogliono raggiungere.
L'Italia delle CER di area vasta sta prendendo forma attraverso queste sperimentazioni concrete. Ogni territorio sta trovando la propria strada, contribuendo a costruire un patrimonio di conoscenze e competenze che sarà prezioso per accelerare la diffusione di questi strumenti della transizione energetica.
La sfida ora è sistematizzare queste esperienze, trasferire le competenze acquisite e supportare i territori che si avvicinano per la prima volta a questi strumenti. Perché le CER non sono solo un contributo alla decarbonizzazione: sono un laboratorio di innovazione istituzionale che può ispirare nuove forme di governance territoriale per le sfide del futuro.
Stimare le emissioni di CO2 nel settore elettrico: confronto tra metodi e una riflessione di policy
I metodi per stimare le emissioni di CO2 provenienti dai diversi settori industriali sono classificati dall’IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change a seconda de...
La ricerca condotta sul Campus Universitario di Palermo dimostra come interventi di retrofit ed energie rinnovabili possano coprire fino all’80% del fabbisogno annuo. La ...
Paola Valbonesi, Direttrice Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", Università di Padova e coordinatrice dello Spoke 6 di Grins, e Marta Castellini,...
2025
2025
Cosa c’è dietro la transizione ecologica? Una call for papers per Rethinking Clusters 2025
Dal 23 al 26 novembre 2025, l’Università di Vale do Itajaí (UNIVALI), in Brasile, ospiterà l’ottava edizione della conferenza internazionale “Rethinking Clusters”, dedica...
2025
2025
Dati, sostenibilità e innovazione: due workshop all’Università di Ferrara
L’8 e il 10 settembre 2025, l’Università di Ferrara ospiterà due giornate di studio su strategie aziendali, impatto socio-economico e contabilità ambientale. Call for pap...
Uno studio condotto dal team di Unisalento (Progetto BAC ECOPOL ENAL) indaga la discrepanza tra l’impatto ambientale reale e quello percepito di alcuni comportamenti sost...
Dietro le quinte delle Comunità Energetiche: cosa racconta davvero la ricerca?
Le comunità energetiche sono celebrate come modelli sostenibili e inclusivi. Ma un'analisi critica della letteratura scientifica rivela contraddizioni profonde tra retori...
Le famiglie italiane e le Comunità Energetiche Rinnovabili: tra interesse e barriere informative
La ricerca su 15.000 famiglie italiane rivela un forte interesse verso le energie rinnovabili. Eppure, il 35% non ha mai sentito parlare delle Comunità Energetiche. Come ...
2025
Filiere agroalimentari sostenibili: il workshop TESSERE a Foggia
Il 13 giugno 2025, presso l’Aula Magna del DEMeT, si terrà il workshop dedicato alla Tematica 7 del progetto TESSERE, nell’ambito dello Spoke 6, WP4.
2025
2025
Un team dell’Università di Palermo parteciperà all’ International Congress on Sustainable Energy and Related Technologies. Il loro studio propone strategie efficaci per l...
Aria purificata in classe: così si riducono le assenze scolastiche
Uno studio sperimentale condotto in scuole primarie milanesi dimostra che i purificatori d'aria riducono l'inquinamento indoor del 32% e le assenze scolastiche del 12,5%,...
Povertà energetica e intelligenza artificiale: il punto a Focus ESG
La professoressa Paola Valbonesi, il professore Stefano Bonetti e l’ingegnere Edoardo Agostini sono intervenuti a ESG per parlare di povertà energetica e soluzioni innova...
Ottimizzazione di Percorsi nel Directed Chinese Postman Problem con Ant Colony Optimization
L’articolo esplora l'applicazione dell'Ant Colony Optimization (ACO) per risolvere il Directed Chinese Postman Problem (DCPP), un problema di ottimizzazione con applicazi...
Mappatura dell’efficienza energetica degli edifici scolastici: dove intervenire?
Il gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara e dell’Università Cattolica (Spoke 6, WP 1) �è impegnato nella mappatura dell’efficienza energetica degli edifici scolastic...
Cambiamento climatico e crescita economica nel Mediterraneo: il costo della non transizione
Lo studio analizza l’impatto economico del cambiamento climatico sul Mediterraneo in assenza di transizione verso le tecnologie verdi, fornendo anche il costo sociale del...
2025
2025
Clima e resilienza: la partnership Grins fa il punto sull’adattamento nei sistemi economici
Il 16 maggio si terrà online il workshop “Adaptation for Climate Resilience”, organizzato nell’ambito dello Spoke 6 del progetto Grins. Ricercatori ed esperti si confront...
Verso un ESG sostenibile e democratico per le PMI
I professori Marco Bettiol e Giuseppe Danese dell’Università di Padova, membri dello Spoke 6 WP4, affrontano il tema della rendicontazione ESG per le PMI, proponendo un a...
Le case italiane sotto la lente: un modello innovativo per capire (e ridurre) i consumi energetici
Un nuovo modello open-source simula i consumi energetici degli edifici italiani combinando fisica edilizia e comportamenti degli utenti. Sviluppato nel progetto GRINS, ai...
2025
Interverranno al convegno, per lo Spoke 6, la prof.ssa Silvia Rita Sedita dell’Università di Padova (leader WP 6.3) e la prof.ssa Daniela Baglieri, che appartiene al BAC ...
Il 19, 20 e 21 marzo 2025 si è tenuto a Cortina d’Ampezzo il convegno dal titolo “Transizione sostenibile, competitività e innovazione: il ruolo della Life Cycle Assessme...
Il nuovo indicatore per per mappare e affrontare efficacemente il problema della povertà energetica a livello locale.
Il gruppo di ricerca del Work Package 6.1 dello Spoke 6, nel corso degli ultimi mesi ha pubblicato due policy brief che fanno il punto sulle ricerche svolte finora sotto ...
Il Rapporto Annuale Istat 2024 ha utilizzato per il secondo anno consecutivo la misura dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (OIPE)
Decarbonizzare, e in fretta: politiche al bivio tra urgenza e rischi di disuguaglianza
L’intervista a Paola Valbonesi, coordinatrice di Spoke 6 e WP 6.4. In collaborazione con Laura Bonacorsi (research manager Spoke 6), Cristina Cattaneo (coordinatrice WP ...
Fonti rinnovabili. Servizi a KM0 delle comunità energetiche
Un’introduzione al concetto di servizi di flessibilità per il sistema elettrico: come coinvolgere le comunità energetiche in questo mercato.
Comunità Energetiche: oltre i decreti, le vere sfide
Estratto dell'articolo di Marina Bertolini e Marta Castellini (Università di Padova) pubblicato da Equilibri Magazine su integrazione sistema elettrico, cambiamento dei c...
Fare rete per ridurre le emissioni di CO2. È l’obiettivo del bando a cascata, aperto fino al 21 dicembre, lanciato dall’Università di Padova capofila dello Spoke 6.
2023
2023
Lo Spoke 6 si riunisce all'Università di Padova per il suo kick-off meeting
Si terrà il 20 e 21 novembre all'Università degli Studi di Padova il primo incontro dei partecipanti allo Spoke 6.
Fondazione GRINS
Growing Resilient,
Inclusive and Sustainable
Galleria Ugo Bassi 1, 40121, Bologna, IT
C.F/P.IVA 91451720378
Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 (Infrastruttura e ricerca), Componente 2 (Dalla Ricerca all’Impresa), Investimento 1.3 (Partnership Estese), Tematica 9 (Sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori).